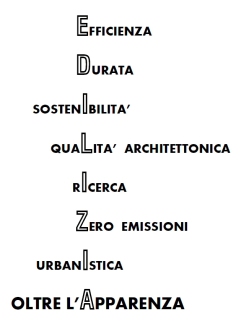LA SCUOLA COME ORGANISMO
Per affrontare un progetto di edilizia scolastica consapevoli della complessità funzionale e spaziale che è necessario saper gestire, sarebbe bene ricordare un po’ di storia.
Nell’età contemporanea è aumentata molto l’abitudine ad una informazione per “spot”, va però tenuto presente che in certi casi è necessario uno studio diverso, apparentemente più tradizionale, ma, in realtà, quanto mai attuale e appropriato per dotarsi dell’attrezzatura culturale necessaria per affrontare progetti che devono poter fornire i giusti ambienti in cui promuovere lo sviluppo culturale e psichico di intere generazioni.
Andrebbe considerata su tutte la lettura delle 300 pagine scritte dal Prof. Arch. Ciro Cicconcelli sui manuali di “Architettura Pratica” di Pasquale Carbonara. Poi le norme tecniche del 1975, curate sempre da Ciro Cicconcelli in qualità di direttore del Centro Studi del Ministero della Pubblica Istruzione.
Andrebbero poi studiate le tipologie scolastiche più significative che i programmi sperimentali del Centro Studi consentirono di realizzare.
Seppur oggi disponiamo di normative tecniche in materia di efficienza energetica, comfort acustico, standard di sicurezza antincendio e strutturale ben più avanzate rispetto agli anni ’70, abbiamo forse un po’ tralasciato il valore “compositivo-funzionale dell’organismo scolastico” verso il quale, quelle norme del ’75, indirizzavano.
In questa sede si vuole offrire un piccolo compendio di informazioni storiche che possono risultare di grande aiuto a chi deve affrontare temi così delicati come quello di costruire gli spazi dell’istruzione e dello sviluppo civico dei bambini e degli studenti di tutte le età.
EDIFICIO E ORGANISMO
Se pensiamo all'edificio scuola per quanto rappresenta nei ricordi comuni, non possiamo che riferirci essenzialmente alle due tipologie più diffuse: il compatto istituto del primo novecento in zona centrale e la scuola prefabbricata in periferia. Del primo generalmente si ricordano le notevoli altezze dei soffitti e delle finestre ed i lunghi corridoi; della seconda l'aspetto da costruzione industriale e, a volte, la lunga finestra a nastro delle aule. Di ognuna ricordiamo il contesto urbano in cui era inserita: il tessuto ortogonale e compiuto del quartiere ottocentesco o il senso di provvisorietà dell'area periferica. Pochi e semplici elementi di giudizio che, nei casi più fortunati, possono arricchirsi con il ricordo di una complessiva qualità decorativa esterna o di un'aula provvista di qualche attrezzatura da laboratorio.
Se invece la conoscenza o il ricordo si sposta verso scuole "speciali", che per caso abbiamo avuto modo di visitare, avvertiamo la necessità di descrivere la costruzione nel suo insieme e non solo per qualche aspetto particolare. Prendiamo ad esempio un monastero sugli Appennini, non propriamente una scuola, ma certamente un luogo di attività culturale oltre che di culto e vita contemplativa. Nel ricordo appaiono subito la chiesa ed il chiostro, elemento di raccordo con gli altri ambienti: la sala riunioni, il refettorio, le celle. Poi, l'inserimento del monastero tra i monti, i porticati interni, gli orti. E' già un'immagine di complessità organizzativa e compositiva. Non possiamo più definire il monastero un edificio. Per meglio denominare una costruzione costituita da più corpi, nella quale le attività si svolgono secondo la disposizione più confacente alla funzionalità complessiva interna, che trovi nel complesso degli agenti atmosferici esterni e nell'inserimento nel territorio le ragioni della propria conformazione spaziale e della scelta dei materiali, una corrente del'architettura moderna ha preferito il termine organismo.
La differenza tra edificio ed organismo, più che dal numero delle funzioni che vi si svolgono, dipende da come queste si pongono in relazione tra loro e con l'esterno. La chiave di lettura della genesi progettuale, nell’architettura organica, è che il progetto nasce sempre "dall'interno verso l'esterno", ovvero dalla distribuzione interna delle funzioni e dal complesso delle relazioni che queste assumono tra loro e con il contesto esterno. Di conseguenza la forma dell'involucro deriva da ciò che deve contenere e da quanto sia necessario perché si rapporti con l'esterno nel modo più idoneo.
"La realtà di un edificio non consiste nelle mura e nel tetto,ma nello spazio in cui si vive" (Lao Tze).
L'edificio coerente con questa massima diventa organismo. Tutti i finti tempietti realizzati nella passata stagione post-moderna non possono avere nulla in comune con quanto vorrebbero rappresentare perchè la loro realtà interna è diversa da quella del tempio. Se capovolgiamo una barca e la usiamo come tetto, riusciamo anche a ripararci dalla pioggia, ma il viverci sotto non equivale al navigare in mare.